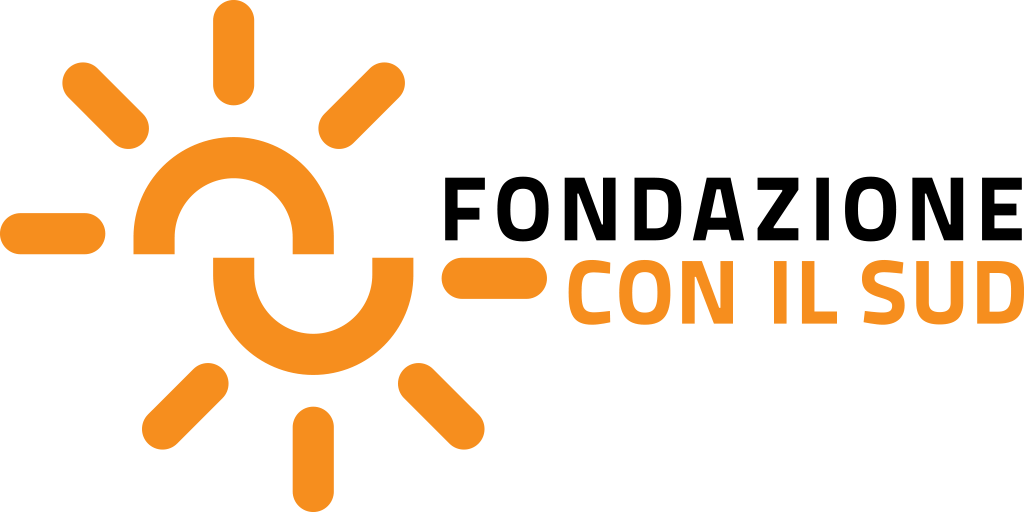Non esiste nessuna diversità antropologica dei meridionali. Intervista ad Alessandro Leogrande
ROMA - 28 Novembre 2017

In ricordo di Alessandro Leogrande, giornalista e scrittore tarantino, scomparso prematuramente domenica 26 novembre.
“Non esiste nessuna diversità antropologica dei meridionali”. La critica alla retorica del disastro di Alessandro Leogrande, tratto da “CON IL SUD – Visioni e storie di un’Italia che può cambiare”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD, a cura di a cura di Andrea Di Consoli e Yari Selvetella, edito Mondadori.
Alessandro Leogrande, la Fondazione Con il Sud compie dieci anni, e in questo frangente ci domandiamo cosa sopravviva oggi della “questione meridionale”, che ha di fatto descritto il Sud come una terra “diversa” rispetto alle altre. In cosa consiste, se c’è, questa “diversità”?
Penso che l’Italia sia plurale e stratificata, e che vi siano numerose specificità che però – e qui sta il punto – sono determinate storicamente e non antropologicamente. Abbiamo appena chiuso un numero speciale della rivista Lo straniero sul Trentino, il Sudtirolo e il Friuli, e abbiamo raccontato le alterità e le specificità di quest’area del Paese. Non c’è dunque solo un’alterità meridionale, ma l’Italia intera, per la sua giovane unitarietà, mostra una straordinaria pluralità, molto più della Francia, per esempio. All’interno di queste particolarità si colloca la specificità meridionale, che è anzitutto una specificità storica. Per comprenderla a fondo bisogna ritornare al grande meridionalismo dei Villari, dei Nitti e dei Croce, che quando parlavano di questione meridionale partivano sempre dalle ragioni storiche e politiche, convergendo tutti sulla richiesta di più Risorgimento e di più unità nazionale, ovviamente all’interno di un assetto di pensiero d’impianto illuministico e cosmopolita. Invece negli ultimi vent’anni, con l’esaurirsi del meridionalismo storico e politico, nel Mezzogiorno è emerso un meridionalismo antropologico, un’ideologia dell’alterità antropologica del Sud che è poco convincente, tanto che non sono mai riuscito a individuare in cosa consistesse questa presunta diversità antropologica. Il rischio di un simile approccio è di determinare una sorta di “orientalismo” esotista, un’ideologia della separatezza e della “diversità” che trovo senza fondamento e fuori luogo, soprattutto in un contesto dinamico e aperto come quello del mondo contemporaneo.
Quindi, per dirla con uno slogan, la “questione meridionale” è viva, mentre la “questione dei meridionali” è morta.
C’è senz’altro un ritorno della “questione meridionale”, che si accentua soprattutto in occasione della diffusione dei dati della Svimez, oppure dell’Istat e del Censis. Al di là di alcune eccezioni, il quadro socio-economico che emerge del Sud è sempre negativo, dalla disoccupazione alla desertificazione produttiva fino alla nuova emigrazione intellettuale e proletaria. Questo quadro preoccupante dovrebbe secondo me determinare la necessità di una riflessione approfondita sui problemi del Sud. Aggiungo che in questi anni il cinema, la letteratura, il giornalismo, la reportagistica hanno raccontato con grande forza le questioni più profonde del Mezzogiorno, e questo lavoro va rivendicato anche con orgoglio, perché ci sono alcune opere degli ultimi anni che possono tranquillamente stare al livello di Un popolo di formiche o di Africo. Cosa manca però rispetto al passato? Manca la comunicazione tra la produzione intellettuale e il mondo politico, è scomparso quel tavolo di confronto che permetteva a chi forniva queste letture di avere sponde non solo istituzionali ma anche presso le parti più attente del mondo politico. Ho la sensazione che oggi questi due mondi camminino separatamente, tant’è che si fa molta a fatica a trovare pezzi di politica disposti ad affrontare i temi di più lungo respiro del Sud.
Il mondo culturale non ha proprio nessuna colpa? Non è grave, per esempio, che gli intellettuali in generale considerino con ingenuità la politica, considerandola moralisticamente “sporca” e inutile?
Credo ci siano responsabilità da ambi i lati. Aggiungo che è molto difficile a questo livello della discussione separare i tic e gli arroccamenti della cultura nazionale da quelli meridionali. Penso comunque che quel che sta mancando sia alla cultura che alla politica sia un riformismo radicale post-ideologico. Purtroppo si procede con frasi fatte sulla lentezza o sull’alterità, oppure con frasi fatte sullo status quo amministrativo. Credo invece che sia necessario un riformismo radicale che eviti le frasi fatte e che permetta di analizzare la realtà con disincanto e concretezza. Questo manca quasi sempre, nell’approccio intellettuale.
Si predilige la suggestione emotiva all’analisi della complessità.
Tutte le analisi per cui di notte le vacche sono nere non portano da nessuna parte. Recentemente ho fatto un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno dove ho commentato il grave incidente ferroviario che è avvenuto in Puglia, tra Andria e Corato, il 12 luglio del 2016. In quest’articolo ho tentato di disarticolare la retorica del disastro, smontando la suggestione sbagliata del “treno dei poveri” o della “strage della povertà”. Quest’incidente è avvenuto per un difetto di comunicazione, per un problema di natura tecnica diciamo così, che non c’entra niente con l’arretratezza, ma piuttosto con una modernità a pezzi scomposti. Noi dobbiamo fare i conti con questa modernità che ingloba elementi pre-moderni, ma senza esotismi o retoriche apocalittiche. Ieri sera ho fatto una lezione a Celle Messapica. Terminata la lazione mi hanno portato in una masseria bellissima circondata da olivi secolari che è tenuta da un bravissimo agronomo con il quale ho conversato a lungo e piacevolmente. Dal mio punto di vista quello era uno dei posti più belli e meglio tenuti al mondo. Come si fa perciò a leggere semplicisticamente o univocamente la realtà meridionale, che pure ha molti nodi irrisolti, e penso all’Ilva di Taranto? Una lettura profonda della realtà deve tenere conto della compresenza di tutti questi elementi, e ovviamente rifiutare il punto di vista di chi vede solo il disastro. Si tratta poi di trovare le parole giuste per raccontare la realtà per quello che è, ma ciò richiede una posizione di equilibrio, altrimenti si finisce con il fermarsi ai cliché o a ingenuità che spiegano poco.
Hai appena citato l’Ilva di Taranto, della quale ti sei occupato tanto. Pensi che la contraddizione che lì è esplosa tra lavoro e salute sia un tema esclusivamente meridionale, oppure un tema europeo e, ingenerale, occidentale?
Credo si tratti di una questione occidentale. Il problema della difficile convivenza tra diritto al lavoro, diritto alla salute e tutela ambientale è una questione cruciale dei giorni nostri, soprattutto in Europa. Poi, certo, c’è anche una dimensione legata specificatamente a Taranto, alla sua storia particolare, alle sue tante sedimentazioni. Ma ritengo che il problema sia molto più largo. Anche qui: come si esce dai tanti cliché contrapposti? Com’è possibile far valere un pensiero riformista avanzato che è consapevole che si può produrre e dare lavoro in maniera diversa rispetto al passato, evitando i tanti errori fatti sia nella fase pubblica che in quella privata? Quello dell’Ilva di Taranto è il classico caso in cui è possibile saltare la retorica dell’alterità meridionale, anche perché non capisci questa grande realtà industriale se non hai uno sguardo globalizzato, perché va da sé che se ignori l’andamento del mercato dell’acciaio in Cina non puoi capire nulla nemmeno della produzione dell’acciaio a Taranto.
Altro tema che hai affrontato con grande impegno è il caporalato, che chiama in causa tanti temi: l’agricoltura meridionale, l’immigrazione, i diritti dei lavoratori, i sindacati.
Il mondo del caporalato e del bracciantato è composito e frammentario, e cambia continuamente, perché è quello più legato alla globalizzazione, paradossalmente. Credo che il lavoro in agricoltura sia oggigiorno il banco di prova della società tutta, perché qui si esprime il massimo dello sfruttamento e, al contempo, il massimo della globalizzazione dei processi produttivi. La manodopera che raccoglie il pomodoro nel Tavoliere delle Puglie è al 99% straniera, e questa manodopera non ha il diritto al voto. Il pomodoro raccolto, invece – che non è il pachino da tavola – finisce addirittura nel ketchup che si consuma in Inghilterra. Com’è evidente, è un mondo molto complesso: avanzatissimo e, allo stesso tempo, arcaico. Tenere conto della complessità del fenomeno è compito della politica ma anche del sindacato, che è costretto a fare i conti con questa continua scomposizione dei livelli produttivi. Una cosa è certa: non si esce da tutto questo groviglio con una politica repressiva. Però si avverte la necessità di organizzare questo fronte di nuovi lavoratori su scala globale, trovando soluzioni intelligenti e concrete. I caporali non traggono la propria forza dal sadismo, come molti pensano, ma dal fatto che se domani mattina ti servono quaranta persone disciplinate che ti lavorano nella terra per pochi soldi loro sono in grado di garantirti quest’offerta, che semplicemente è vincente sul mercato. Il problema semmai è dello Stato, che non riesce a offrire forme altrettanto efficaci di collocamento pubblico, così da potersi sostituire ai caporali nella mediazione della domanda e dell’offerta. Nel silenzio dei campi, oggi il caporalato è ancora un modello difficilmente disarticolabile, come tante zone grigie del lavoro al Sud, che non basta condannare, ma anzitutto capire e fotografare.
Da questo Sud di chiaroscuri e di laceranti contraddizioni si continua ad andare via.
Non ho mai demonizzato l’emigrazione, penso che le vite di quanti viaggiano ed emigrano siano in generale più attive di quelle di chi rimane a rigirarsi i pollici, e mi riferisco soprattutto all’altissima percentuale di giovani che né studiano né lavorano. Siamo una società globale dove ci sono identità plurali. Io stesso sono pugliese ma anche romano, e a volte mi sento più romano dei romani, anche se siamo percepiti come “forestieri”. La consapevolezza di questa identità plurale è anche complicata, però credo che sia una ricchezza, benché poco valorizzata politicamente. Penso per esempio che le politiche locali abbiano una scarsa attenzione nel relazionarsi con quanti sono andati via, con la diaspora. Ma non nella direzione di pensare a come farli ritornare, ma mettendo in campo una politica della distanza e dell’interazione, anche utilizzando i nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione.
Esiste al Sud un problema di subculture e di nuovo analfabetismo?
Ovviamente Tullio De Mauro risponderebbe di sì. E credo anch’io che ci sia un problema legato all’analfabetismo di ritorno. Il tema, perciò, non può essere aggirato. Da un punto di vista più profondo rilevo una cosa, alla quale ho pensato qualche giorno fa rileggendo Ragazzi di vita di Pasolini, che un editore albanese ha deciso di tradurre, chiedendomi di scrivere la prefazione. Leggendo il romanzo di Pasolini mi sono chiesto come un traduttore possa rendere quello slang che oggi, semplicemente, non esiste più, perché socialmente la Roma di Pasolini è scomparso per sempre. Sai perché dico questo? Perché se ripenso al cinema della mia formazione giovanile, al cinema del Sud degli anni ’90, quello dei Martone, dei Capuano, dei Ciprì e Maresco, io ho il sospetto che tante di quelle cose, oggi, siano incomprensibili. E ripeto: quella è la mia formazione, sto parlando di cose che sono molto importanti nella mia vita, cose che ho amato. Oggi una ragazza di Scampia o dello Zen di Palermo ha gusti musicali simili a quelli di una ragazza del centro di Roma, perché è radicalmente cambiato il gusto e l’accesso alle cose culturali. Forse si sono addirittura ridotte le distanze culturali di un tempo, anche se chiaramente permangono quelle sociali. Allora io penso che nelle periferie del Sud e nei luoghi più marginali è sì cresciuto rispetto a vent’anni il silenzio, ma è come se si fosse attenuata la distanza rispetto al resto del Paese e del mondo. Per questo funziona poco la retorica del disastro. Funzionerebbe molto di più un racconto nuovo per interpretare e restituire questo silenzio che è il suono di una nuova trasformazione che forse ci sta sfuggendo. Una cosa è certa: parole come “omologazione” e “piccola-borghesia” non servono a niente e personalmente non le userò mai più.